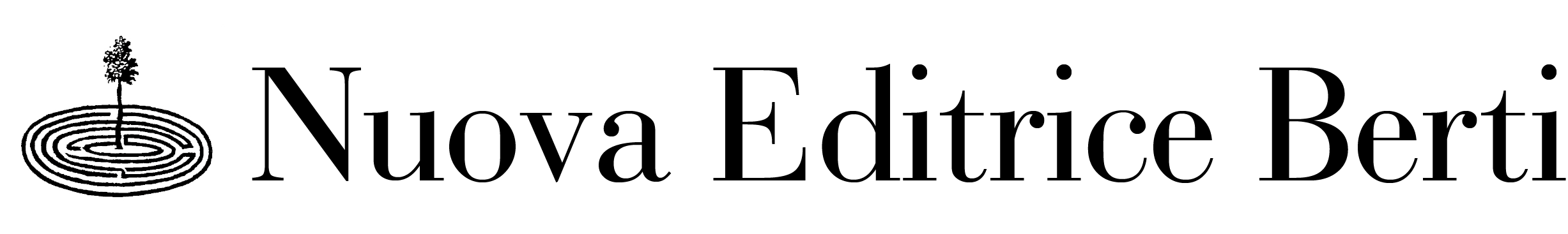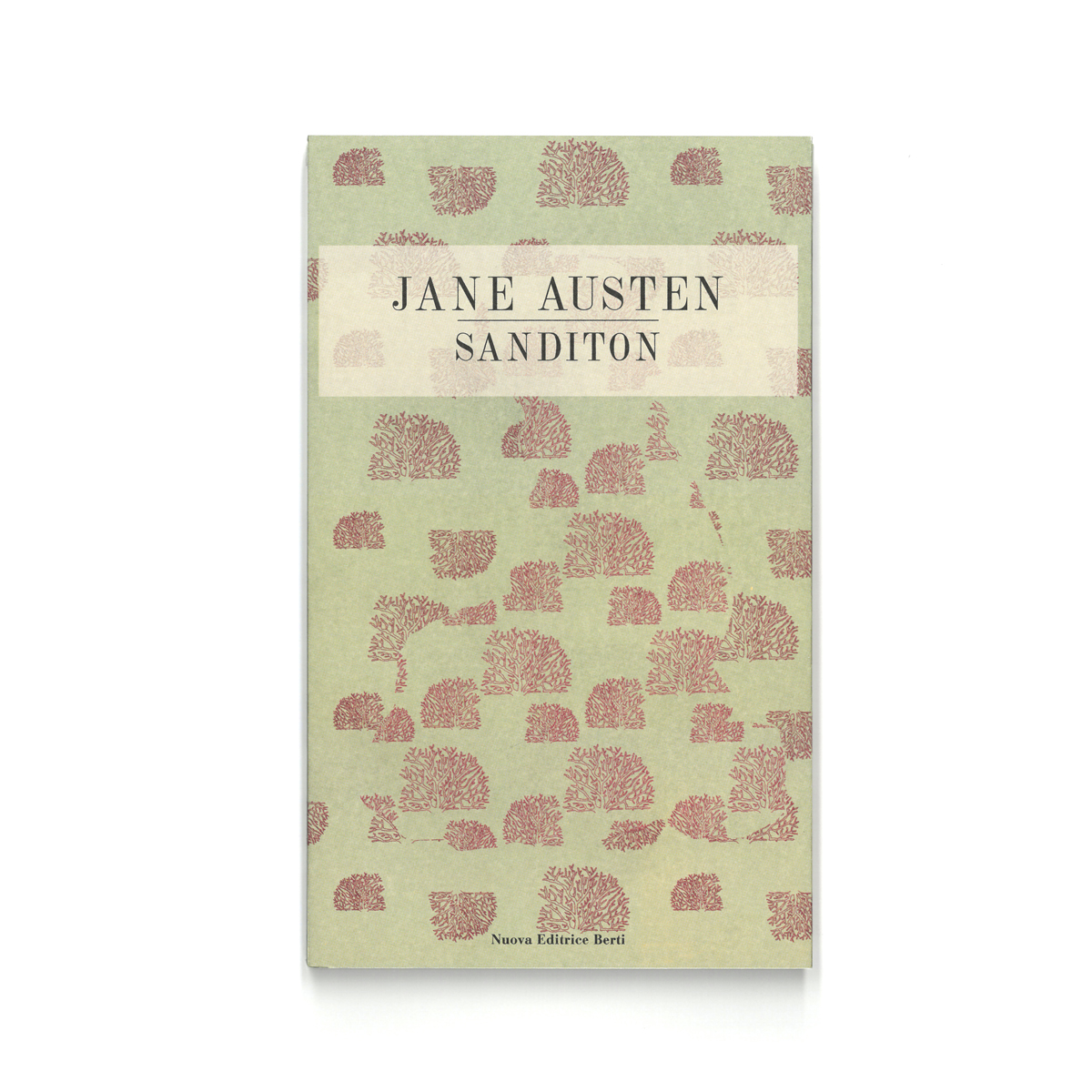Jane Austene la ricerca della felicità
Com’è giusto che sia, tra i lettori anche celebri che si sono confrontati con l’opera di Jane Austen, sono molti gli insospettabili entusiasti (un Samuel Beckett che confessa di leggere “la divina Jane”) e altrettanti i detrattori convinti, che le rimproverano due cose soprattutto: di aver scritto romanzi buoni solo per signorine in cerca di marito (luogo comune sfatato in primis da uno splendido racconto di Kipling, The Janeites, in cui un gruppo di soldati fonda una società segreta le cui parole d’ordine sono tutte collegate a personaggi e situazioni austeniane); di ignorare gli Eventi della Grande Storia.
Entrambe queste critiche sono in parte vere, perché per nostra fortuna Jane Austen se ne infischiava dei grandi temi filosofici che infiammavano gli animi dei suoi contemporanei maschi, concentrandosi sulle relazioni sociali e sulle donne, vere e incontrastate protagoniste dei suoi romanzi.
Quella raccontata dalle eroine austeniane è forse un diverso tipo di storia, lontana dai grandi eventi ma non meno rappresentativa di un’epoca.
Se nei romanzi di Jane Austen si dà tanta attenzione agli aspetti concreti della vita è perché a quei tempi le donne non potevano certo permettersi di lasciare il mondo tra parentesi per analizzarne le implicazioni metafisiche: al contrario, loro il mondo dovevano prenderlo molto sul serio.
Come sottolinea Liliana Rampello nella sua bella introduzione al Meridiano dedicato alla grande scrittrice inglese, Jane Austen, però, introduce una grande, determinante innovazione e libera le “sue” donne dalla condizione di vittime. Con Jane Austen assistiamo infatti a un cambiamento radicale di prospettiva, perché nei suoi romanzi quello che occupa l’intera scena è il desiderio di felicità individuale, la costruzione della propria soggettività: se fino ad allora il romanzo settecentesco rappresentava la donna secondo il collaudato schema sedotta/seduttrice, perbene/permale, e il matrimonio era una conclusione inevitabile, quasi l’interiorizzazione passiva di una norma sociale, per la giovane eroina austeniana il finale da fiaba è un meritato traguardo, l’esito di una ricerca: la ricerca della felicità.
Quelli di Jane Austen sono, a tutti gli effetti, romanzi di formazione femminile, in cui delle giovani donne, delle ragazze, costruiscono il proprio destino. Lo fanno ognuna a modo suo, seguendo ogni volta la propria indole e le proprie inclinazioni, e riconoscendo i limiti di una condizione sociale che non permette altre forme di ribellione oltre all’ironia. Le ragazze descritte da Miss Austen si ritagliano di diritto il proprio ruolo nel mondo in cui si trovano a vivere, senza lamentele o recriminazioni, ma con intelligenza: si sposano, com’è ovvio che sia, ma in modo consapevole, scegliendo liberamente, e bene, un buon marito, imparando cioè a distinguere tra le diverse forme in cui si presenta l’amore e pretendendo per sé tutta la felicità d’amare ed essere amate.
Fra le molte righe che Virginia Woolf dedica a Jane Austen, da lei definita “l’artista più perfetta tra le donne” c’è un passaggio in cui la paragona a Shakespeare, e lo fa non per l’abilità con cui sa cogliere i dettagli e le sfumature psicologiche, o per il ritmo superbo dei suoi dialoghi, ma per lo slancio con cui la sua mente trascende le condizioni contingenti e ogni ostacolo materiale, nella piena consapevolezza del proprio valore artistico di scrittrice.
La voce di Jane Austen, sgombra di ogni recriminazione verso un secolo che l’avrebbe voluta relegata al ruolo moglie, madre o triste zitella, risuona così in tutta la sua androgina libertà, e parla alle giovani donne di ogni tempo e di ogni luogo spronandole ad avere fiducia nei propri princìpi, a non andare mai contro la propria volontà, e a cercare sempre, sempre, sempre un possibile, personalissimo lieto fine.